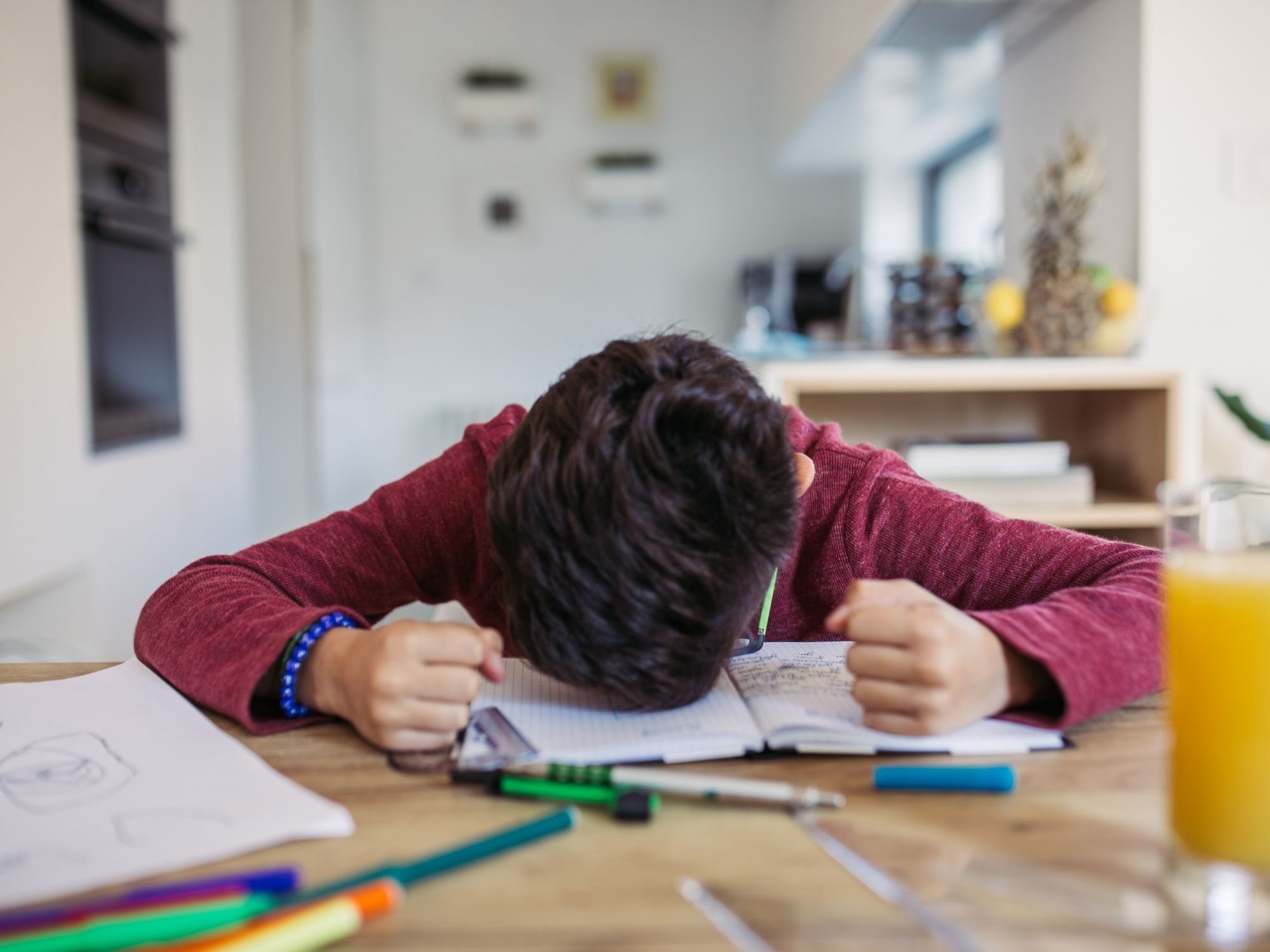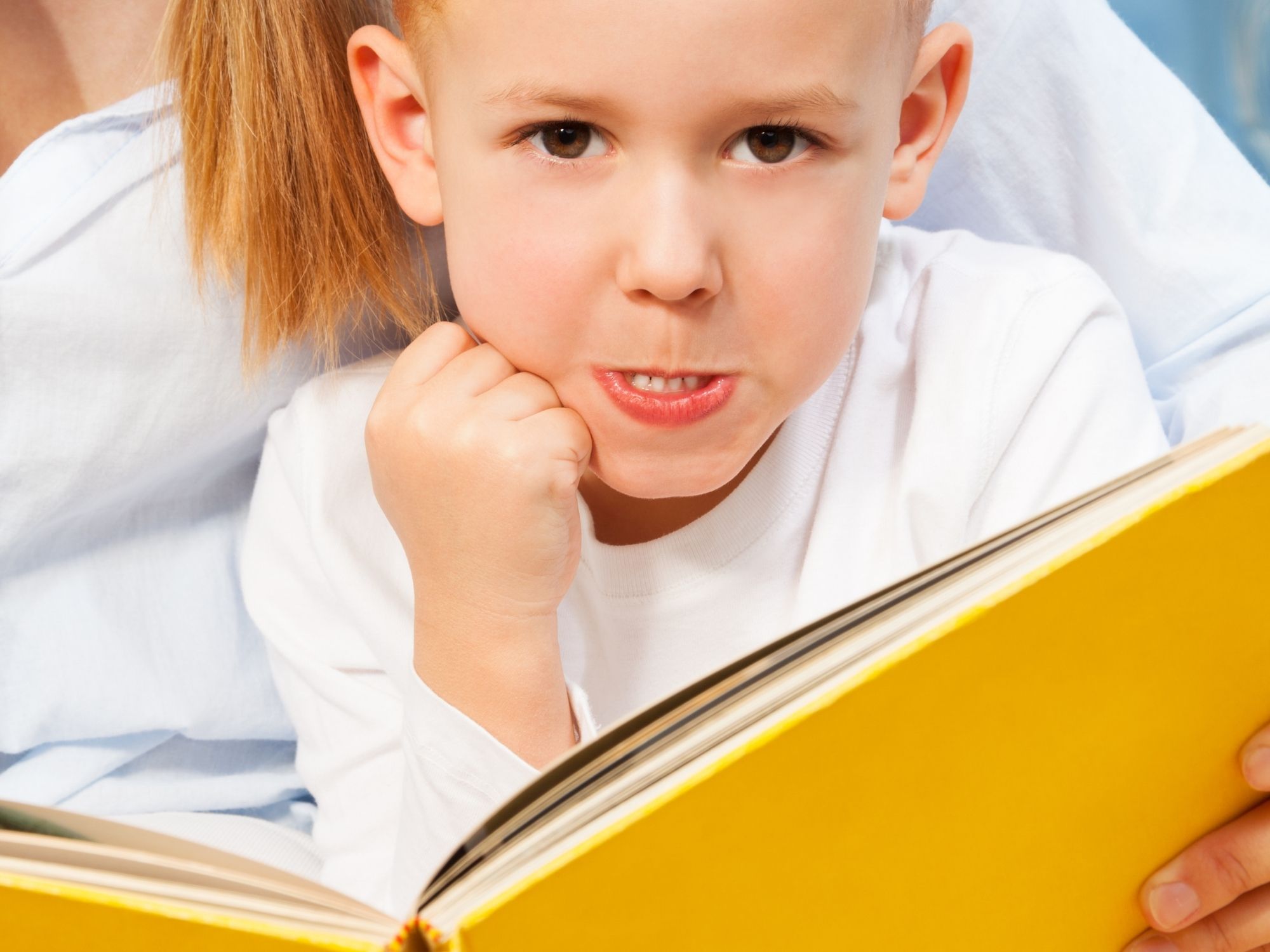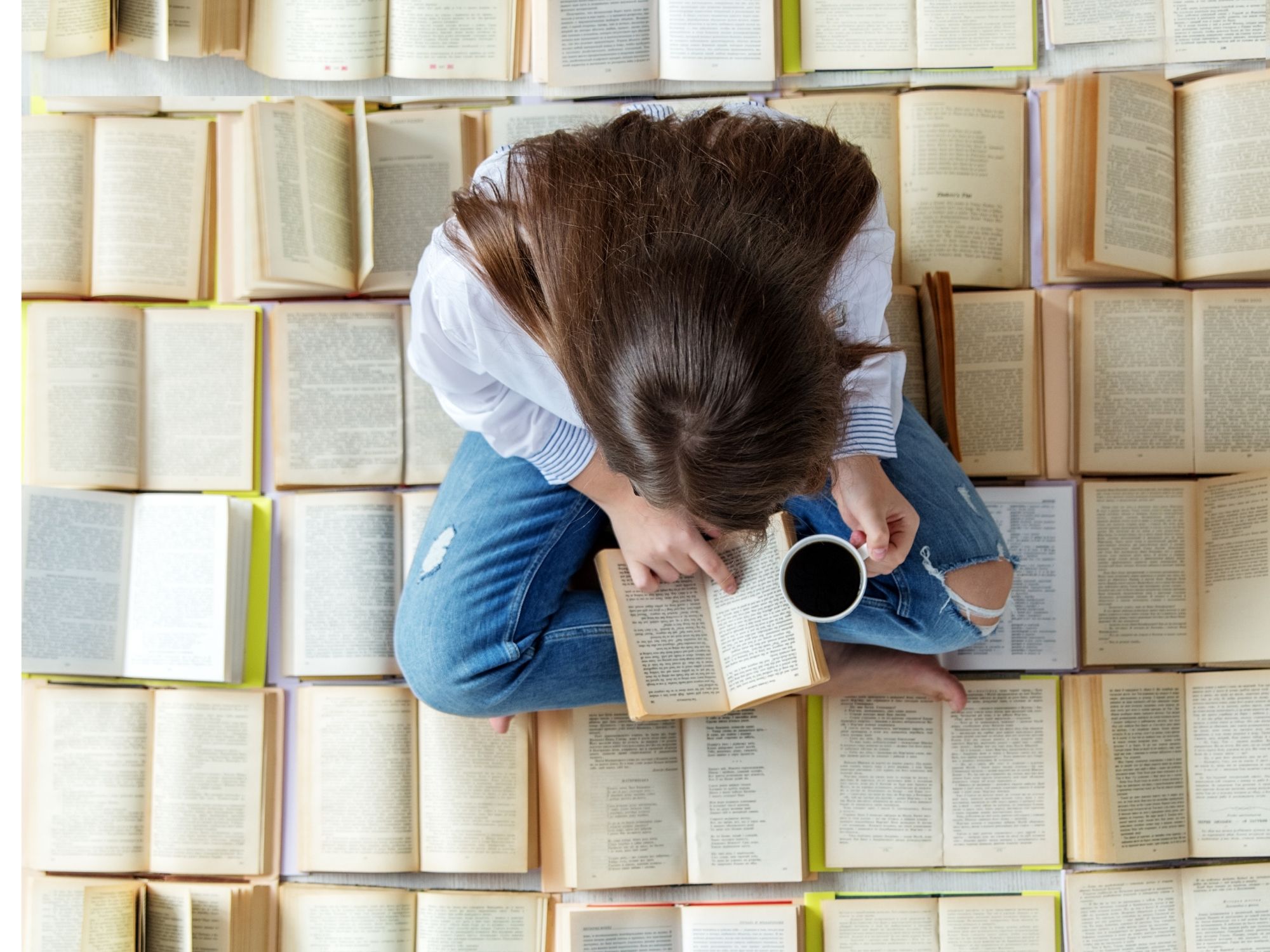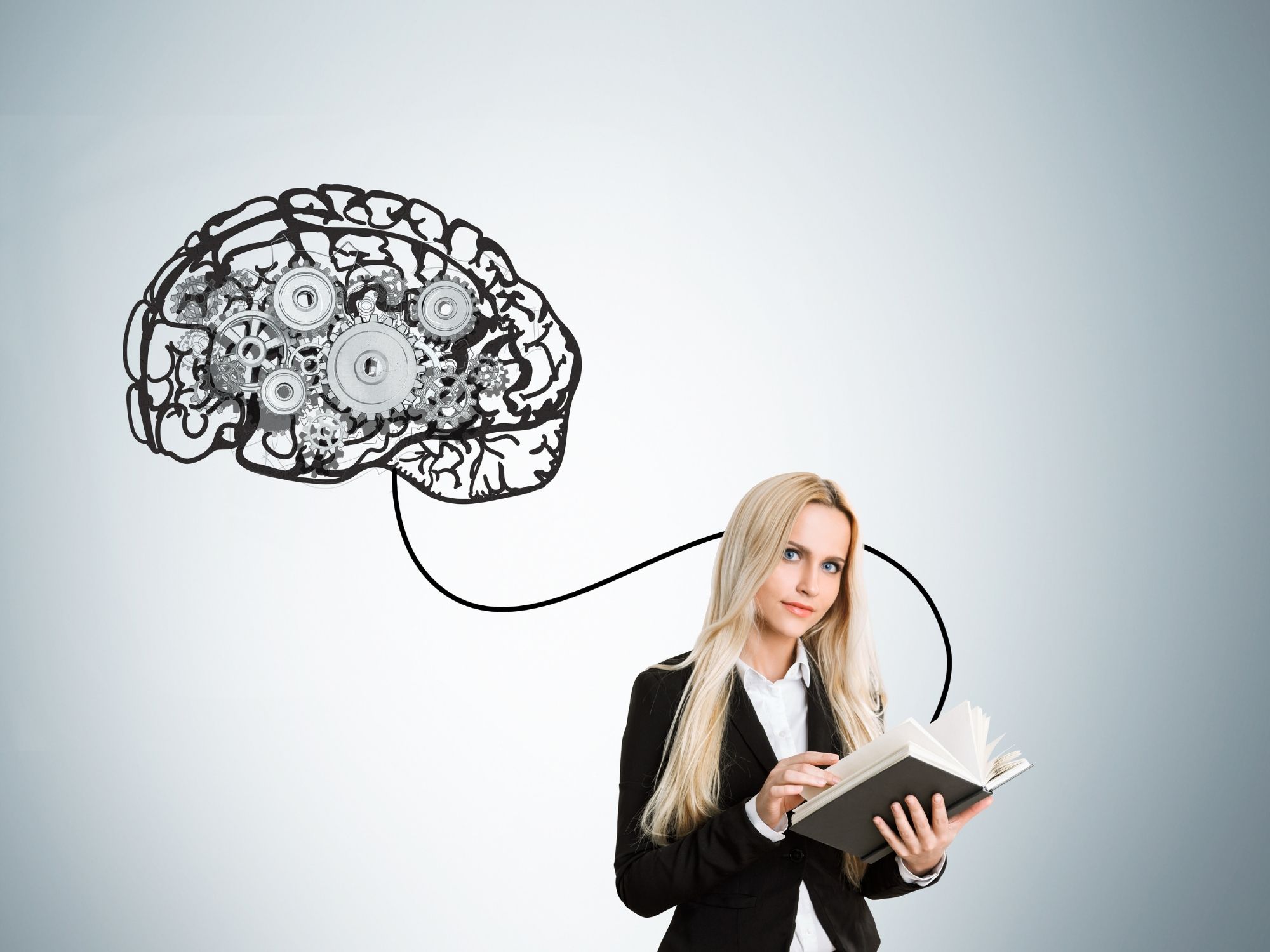La socializzazione nei primi tre anni: tra mito e realtà scientifica
Negli ultimi anni, complice la diffusione dei social e di contenuti emotivamente forti, si è fatto largo un mito pericoloso.
Un pensiero dilagante suggerisce infatti che i bambini sotto i tre anni non abbiano bisogno di socializzare con altri bambini. Questa affermazione, sebbene apparentemente protettiva, non trova riscontro né nelle neuroscienze dello sviluppo, né nella pedagogia contemporanea.
Anzi, rischia di minimizzare il valore educativo della relazione tra pari, anche in età precocissima, quando venga proposta in ambienti sicuri e relazionalmente competenti.
La prima infanzia è relazione
Fin dalla nascita, il bambino è un essere sociale: cerca lo sguardo, riconosce le voci, si orienta verso chi gli parla. Non è vero che il bisogno di relazione compare solo dopo i tre anni: è biologicamente presente fin dai primi giorni di vita.
«La mente del bambino è costruita nel contesto della relazione» (J. P. Shonkoff, The Science of Early Childhood Development, Harvard University, 2010)
Non a caso, secondo Daniel Stern, lo sviluppo del sé si fonda su quella che chiama intersoggettività primaria (1998): un dialogo affettivo e corporeo tra bambino e adulto che si estende presto anche ai pari.
Quando un bambino di un anno guarda un altro bambino che piange, ride, prende un oggetto, sta già costruendo competenze empatiche e regolative.
Socializzare prima dei 3 anni: sì, ma con qualità
Certo, nei primi anni di vita il gioco tra bambini è spesso parallelo (ognuno gioca per sé, ma vicino all’altro). Ma questo non significa che non sia socializzazione.
«Il gioco parallelo è una delle prime forme di interazione tra pari. Rappresenta una fase fondamentale di osservazione, imitazione e regolazione emotiva» (L. Pulkkinen, The Development of Social Behavior, European Journal of Psychology of Education, 2006).
I bambini imparano a: regolare il proprio comportamento rispetto agli altri aspettare il turno riconoscere i segnali emotivi sviluppare la teoria della mente (capire che l’altro pensa, sente e vuole in modo diverso).
Queste micro-esperienze relazionali precoci – se guidate da educatrici competenti e in ambienti emotivamente sicuri – pongono le basi per l’autoregolazione, la resilienza e la capacità di cooperare nel lungo termine.
Cosa dice la neuroscienza oggi
Il cervello del bambino nei primi tre anni è in rapidissima espansione sinaptica: ogni interazione significativa modella le reti neurali.
Uno studio del Center on the Developing Child (Harvard, 2021) dimostra che le interazioni ripetute, prevedibili e sicure – anche con pari – rafforzano il sistema limbico (regolazione emotiva) la co-presenza di adulti responsivi in contesti educativi è protettiva e arricchente, anche per bambini molto piccoli.
Non è la presenza esclusiva della madre a essere fondamentale, ma la qualità della cura e della relazione, anche se mediata da figure diverse (padri, educatori, nonni, pari…).
Il ruolo dell’asilo nido (o baby parking) ben gestito
L’asilo nido non è solo spesso una necessità sociale, ma soprattutto può essere un’opportunità evolutiva importante: permette al bambino di sperimentare la differenza (tra sé e l’altro, tra sé e l’adulto) favorisce l’autonomia affettiva progressiva costruisce schemi di cooperazione precoce e capacità di adattamento
Ovviamente, non tutti i contesti sono adatti: serve un ambiente a misura di bambino, con professionisti formati, stabilità nei riferimenti adulti, rapporto numerico corretto e rispetto dei tempi individuali.
I rischi di una visione riduttiva
Affermare che un bambino sotto i tre anni non ha bisogno degli altri a meno che non ci sia la madre alimenta la colpevolizzazione delle madri lavoratrici e distorce il valore educativo delle relazioni orizzontali precoci semplificando eccessivamente il bisogno di relazione, che è plurale e stratificato, non binario In sintesi
La socializzazione tra bambini piccoli non è superflua, ma fondamentale se guidata e accolta con sensibilità. I bambini sotto i 3 anni traggono beneficio dal confronto tra pari, anche se in modo diverso da bambini più grandi. Non si tratta di “lasciarli tra coetanei a caso”, ma di offrire esperienze relazionali protette, brevi, graduali e cariche di senso.
La qualità della relazione educativa, e non l’esclusiva presenza della madre, è ciò che fa la differenza.
Fonti di riferimento Center on the Developing Child, Harvard University (https://developingchild.harvard.edu) Stern, D. (1998).
The Interpersonal World of the Infant Shonkoff, J.P., Phillips, D. (2000).
rom Neurons to Neighborhoods Pulkkinen, L. (2006). The Development of Social Behavior Fonagy, P. et al. (2002). Affect Regulation, Mentalization and the Development of the Self
Come pedagogista clinico e psicomotricista funzionale, ti invito a guardare oltre i miti e abbracciare una visione più articolata e scientifica della prima infanzia. Il nido non è solo un luogo dove “lasciare i bambini”, ma può diventare un prezioso laboratorio relazionale, se costruito con cura. Per info, letture consigliate o formazione per genitori ed educatori, contattami e seguimi, qui o su Spotify.